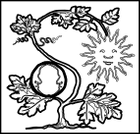di
Silvia Timitilli
È notte, siamo di ritorno a piedi, da soli, da un locale e dobbiamo passare in un vicolo stretto e male illuminato. Stiamo per imboccarlo quando sentiamo degli schiamazzi, vediamo un gruppo di due o forse tre uomini che visibilmente barcollano e sembrano stare spingendosi l’un l’altro. Che fare? Un modo di dire fiorentino sembra suggerire la più pronta soluzione: “Meglio aver paura che buscarne!” e così decidiamo di cambiare strada. Allungheremo il percorso di un cinque minuti abbondanti, magari non avremo nemmeno visto o sentito bene, ma appunto “meglio aver paura che buscarne”: se ci fossimo sbagliati poco male, avremo camminato cinque minuti in più, ma se avessimo avuto ragione non avremmo avuto facilmente la meglio su un gruppetto di uomini ubriachi e aggressivi!
Quella appena descritta è una condotta di evitamento, ovvero una strategia che consiste nel tenersi lontano da quelle situazioni percepite come pericolose.
Abbiamo fatto bene o no in quell’occasione? Facendo un bilancio di costi e benefici, potremmo rispondere con buona approssimazione sì, anche se non abbiamo la certezza che in quel vicolo ci fosse davvero un gruppo di uomini ubriachi e aggressivi. Immaginiamo di leggere nel giornale di cronaca locale, qualche giorno dopo, che proprio quella notte, in quel vicolo, un passante è stato aggredito da un gruppetto di uomini ubriachi. A quel punto, la risposta alla nostra domanda, se abbiamo fatto bene a evitare quella strada quella notte, diviene assolutamente sì! Dunque il comportamento di evitamento messo in atto è stato funzionale! L’evitamento, infatti, è un comportamento adattivo nella misura in cui permette di allontanarsi da una situazione di pericolo o di minaccia reale (o altamente probabile come nel nostro esempio!).
Come mai allora la psicoterapia cognitivo-comportamentale si prodiga tanto nel combatterlo? In altre parole, quando è che l’evitamento diviene disadattivo?
Una prima risposta è la seguente: una condotta di evitamento perde il suo valore adattivo quando si trasforma in una condotta coercitiva che limita le possibilità di esplorazione dell’individuo (Sassaroli et al., 2006). Con il termine esplorazione ci si riferisce a quella classe di comportamenti in cui si ricerca la novità e che ha come finalità l’aumento della capacità predittiva sul proprio ambiente, allargando i nostri confini.
Per meglio comprendere, torniamo al nostro esempio: quella sera abbiamo dato credito a un nostro pensiero, ovvero che passare per quella strada, in quel momento, fosse pericoloso. Immaginiamoci che quella strada dobbiamo in realtà percorrerla ogni giorno perché quel locale si trova vicino al nostro posto di lavoro. Gli orari in cui la percorriamo di solito sono diversi, fino alla sera prima non abbiamo mai fatto potenziali “brutti incontri” in quel vicolo, ma in noi si insinua l’idea che quel vicolo sia pericoloso. Magari ci siamo immaginati che un gruppetto di “delinquenti e ubriaconi” abbia scelto quel vicolo come loro fissa dimora. Il giorno successivo a quella ormai famosa sera poteva ancora avere un senso vederla così, ma a più di un mese ci appare davvero improbabile. Il detto fiorentino ci torna però sempre alla mente appena intravediamo quel vicolo ed è così che da più di un mese allunghiamo la strada di cinque minuti all’andata e di altrettanti al ritorno…e poi in quella strada c’era quel forno di cui ci avevano parlato tanto bene, dove i colleghi trovano quelle focaccine buonissime che si mangiano in pausa pranzo…ci eravamo detti di comprarle prima o poi…vabbè poco male…ci accontenteremo di focaccine meno buone…ed ecco che la nostra possibilità di esplorazione è compromessa!
Immaginiamo adesso che il nostro pensiero “quel vicolo è pericoloso” si estenda col tempo a tutti i vicoli della città, inizieremo allora a pensare “tutti i vicoli sono pericolosi” e decideremo così di evitarli. Passeggiare a piedi nella nostra città diventerà davvero problematico: sperimenteremo ansia vedendo pericoli ovunque e inizieremo a seguire percorsi alternativi con grandi costi in termini di tempo e qualità di vita.
In quest’ultimo caso le nostre possibilità di esplorazione saranno indubbiamente compromesse, ma ci sarà un altro effetto ancora più pesante e deleterio: quella condotta di evitamento è diventata un meccanismo di mantenimento della nostra sofferenza!
Per meccanismo di mantenimento si intende quell’insieme di processi, interni o interpersonali, che contribuiscono a confermare gli schemi e le convinzioni disfunzionali della persona (Castelfranchi et al., 2002). Sostanzialmente è tutto ciò che continua a farci star male, nonostante si desideri stare meglio. Vorremmo infatti tornare a passeggiare nella nostra città in tutta tranquillità, come facevamo prima, ma ormai ci sembra impossibile passeggiare serenamente anche solo nel nostro quartiere!
Questi esempi ci servono per comprendere quanto insidioso e deleterio sia questo fenomeno e ci aiutano a capire come mai la psicoterapia cognitivo-comportamentale tanto si spenda nel combatterlo.
L’evitamento costituisce, infatti, uno dei principali meccanismi di mantenimento della sofferenza psicologica e dunque della psicopatologia. Lo ritroviamo nei cosiddetti disturbi d’ansia, ma anche in altri quadri psicopatologici come la depressione, il disturbo ossessivo-compulsivo, il disturbo da stress post-traumatico e nei disturbi di personalità (solo per citare alcuni esempi).
Come mai l’evitamento costituisce uno dei principali meccanismi di mantenimento della sofferenza psicologica? Come funziona questo fenomeno?
L’evitamento è una modalità mentale e/o comportamentale che consiste nel tenersi lontano da quei luoghi, circostanze, situazioni o sensazioni percepite dall’individuo come pericolose. L’evitamento può quindi riferirsi a situazioni esterne ma anche a stati interni (pensieri, emozioni, sensazioni) e consiste in una strategia messa in atto per riuscire a gestire al meglio le emozioni negative. Lo scopo, dunque, è sottrarsi dall’esporsi a situazioni, persone, eventi o sensazioni temute per evitare di affrontare l’emozione negativa che altrimenti ne deriverebbe e dunque evitare di sperimentare la sofferenza.
La percezione di pericolo può derivare da un’esperienza avversiva effettivamente sperimentata dal soggetto oppure può basarsi esclusivamente su una valutazione dell’individuo. In quest’ultimo caso, dunque, non si è verificata nessuna reale esperienza avversiva, è sufficiente che la persona in questione pensi che quella circostanza sia pericolosa per sperimentare ansia e dunque decidere di non affrontarla.
Di fronte a una minaccia, reale o immaginaria, che produce una reazione di allarme, l’individuo evita di affrontarlo. Appena metto in atto il mio evitamento, sto meglio: la sirena dell’allarme si spegne e io posso tirare un bel respiro di sollievo! “Ho fatto proprio bene! Vedi come sto meglio?!”
Allo stesso tempo, però, confermo a me stesso che quella situazione era proprio da evitare, perché non sarei stato in grado di affrontarla e quando si ripresenterà una situazione simile in futuro resterà in me questo ricordo, questo senso di immediato sollievo e si radicherà in me, ancor di più, la convinzione di non essere capace di fronteggiare quel pericolo. Si innescherà così un circolo vizioso potenzialmente infinito, all’interno del quale le rinunce si ammasseranno, l’idea di me come incapace o inadeguato acquisterà sempre più forza e il mio sconforto prenderà sempre più piede. Dietro a quell’immediato e momentaneo senso di sollievo si cela quindi il vero pericolo: limitare la mia possibilità di esplorare il mondo e mettermi in gioco e, soprattutto, finire per non credere più in me stesso e nella mia capacità di affrontare quella situazione.
Quali sono le emozioni negative temute ed evitate?
Una di queste è l’ansia e negli esempi sopra descritti ne abbiamo fornito un esempio. Altri esempi sono costituiti dagli evitamenti che caratterizzano il disturbo da attacchi di panico, in cui ad esempio la persona eviterà di guidare in macchina su un viadotto per timore di poter avere un altro attacco di panico come già è avvenuto in passato.
Un’altra emozione temuta è la vergogna: l’evitamento di potenziali situazioni di imbarazzo è uno degli elementi cardine che mantiene la fobia sociale. Ad esempio Carlo, invitato a tenere un intervento a un convegno, pensa che non sarà in grado di farlo, che inizierà a balbettare e che tutti se ne accorgeranno e rideranno di lui. Ne è talmente convinto (anche se non è mai accaduto) e per lui sarebbe una cosa talmente terribile se accadesse, che declinerà l’invito, perdendo un’importante occasione di crescita professionale e soprattutto perdendo l’occasione di sperimentare che forse le cose non andranno così come crede, continuando a ritenersi inadeguato, non potendo mai neppure sperimentare che, anche se accadesse, non sarebbe così terribile come crede.
L’evitamento si ritrova anche nella depressione, in cui l’emozione principalmente temuta è la tristezza. Ad esempio, la persona depressa eviterà di alzarsi dal letto e andare a lavoro perché convinto che sarà un’altra giornata terribile e faticosa, piena di rimproveri e quindi l’ennesima riprova del suo scarso valore. Questo comportamento di evitamento, pur dando l’illusione di alleviare momentaneamente il malessere (in quanto sottrae la persona allo sforzo di fare ciò che le risulta difficile e faticoso o che non ha più voglia di fare), in realtà conduce ad un graduale aggravamento del disturbo determinando una profonda ricaduta sull’autostima del paziente. La persona si percepisce sempre di più come incapace, fallita, senza speranza, rafforzando l’idea di non essere più in grado di svolgere le attività precedentemente attuate, aggravando in tal modo la valutazione negativa di se stessa e della propria vita attuale e la sfiducia verso il futuro.
Nel disturbo ossessivo-compulsivo l’emozione temuta è la colpa e il timore di questa, o meglio della possibilità di essere colpevole, farà evitare al paziente di prendere ad esempio la metro perché così facendo eviterà, per una sua eventuale disattenzione, di contrarre una malattia contagiosa e letale (ad esempio l’HIV) che potrebbe trasmetterebbe ai suoi figli, divenendo così responsabile di una immane disgrazia, un’eventualità terribile di cui non potrebbe mai perdonarsi e che va scongiurata ad ogni modo!
Come mai è importante smettere di evitare?
Finché continueremo a evitare daremo ragione a quella convinzione che quell’emozione o quella eventualità siano così catastrofiche per noi e quindi così inaffrontabili.
Obiettivo della terapia cognitivo-comportamentale sarà dunque eliminare la condotta di evitamento, facendo in modo che la persona possa mettersi nuovamente in gioco, sperimentando “sulla propria pelle” che quelle situazioni e emozioni temute non sono poi così inaffrontabili, tornando a credere in se stessa, nelle sue capacità di fronteggiamento e recuperando una soddisfacente qualità di vita.
Per approfondimenti:
Castelfranchi, C.; Mancini, F.; Miceli, M. (2002). Fondamenti di cognitivismo clinico. Bollati Boringhieri, Torino
Mancini F. (2016). La mente ossessiva. Curare il disturbo ossessivo-compulsivo. Raffaello Cortina Editore, Milano.
Rainone A. e Mancini F. (a cura di) (2018). La mente depressa. Franco Angeli.
Sassaroli, S.; Lorenzini, R.; Ruggiero, G. M. (a cura di) (2006). Psicoterapia cognitiva dell’ansia. Rimuginio, controllo ed evitamento. Raffaello Cortina Editore, Milano.