Capita spesso che si arrivi a chiedere aiuto ad un terapeuta quando la sofferenza è andata ben oltre il limite di sopportazione, magari si ha da mesi nel portafoglio il biglietto da visita dello psicoterapeuta consigliato dall’amica, o da tempo si è cercato e trovato il riferimento in rete, ma il momento giusto per fare la prima telefonata arriva quando si ha la percezione di non poter più fare altro, di non sapere più dove sbattere la testa.
A quel punto la situazione è così ingestibile e provoca così tanto dolore, che quasi si chiede il miracolo. Il terapeuta lo si vorrebbe un po’ genitore buono e accudente, un po’ sciamano dotato di un sapere raro e di poteri speciali.
Essere accoglienti e non giudicanti sono requisiti base per il mestiere di terapeuta, essere maghi carismatici è un elemento accessorio e forse non correla positivamente con il buon esito della psicoterapia, anzi depone a favore di un disturbo di personalità del curante.
Chi sceglie questo mestiere, per ruolo, fornisce aiuto alle persone, non per questo però ha una soluzione immediata ad ogni problema, tanto meno sfugge alle regole dell’umano sentire. Ognuno di noi può ritrovarsi nell’arco di vita in una situazione in cui la sofferenza si blocca e il tempo da solo non basta a lenirla.
Come terapeuta può capitare proprio di desiderarla una bacchetta magica che faccia stare tutti bene immediatamente e che dia l’impressione che la situazione sia sotto controllo, ciò può far sentire utili e speciali, anche se il merito andrebbe tutto della bacchetta e alla formula magica declamata.
Per fortuna però sono davvero rare le volte in cui in uno studio privato ci si trova di fronte ad un codice rosso. L’ambulatorio in cui si svolge la libera professione non è un pronto soccorso e le emozioni, nemmeno quelle più disturbanti, sono di per sé pericolose. Anzi, sono le emozioni intense e sgradevole a svelare l’essenza della sofferenza: sono il filo d’Arianna che conduce al cuore del problema. Le prime sedute prevedono una ricostruzione dei circoli viziosi in cui si è incastrato il disagio, come si è generato e come si mantiene. Prima di avere il quadro chiaro non viene attuato alcun intervento, ma il fatto stesso di riordinare le idee, dare un nome a certe sensazioni, capirne le interconnessioni con i fatti, i pensieri e i comportamenti spesso restituisce un primo sollievo. È come se venisse reso noto il documento di identità del problema e questo dà un senso di maggior controllo perché si capisce meglio contro cosa si sta lottando.
Le nostre emozioni, anche quelle spiacevoli, hanno una precisa funzione e si attivano per gestire una situazione (la paura ci prepara ad affrontare un pericolo, la rabbia un danno ingiusto, la tristezza predispone un nuovo assetto alla luce di una perdita, ecc…), passata l’emergenza, di solito si ridimensionano da sole. Può capitare che la sofferenza si cronicizzi e stati emotivi intensi stringano una morsa intorno alla vita della persona, limitandone il funzionamento lavorativo e sociale e impedendo l’accesso a condizioni di soddisfazione e benessere.
Spesso la richiesta di aiuto psicologico viene vissuta come segno di debolezza: l’evidenza che non si sa gestire da soli i propri problemi. In effetti è sempre più facile gestire quelli degli altri e questo noi terapeuti lo sappiamo bene, così come tutte le persone, amiche e conoscenti che hanno, loro, la ricetta semplice ed efficace per problemi non loro. Quando una difficoltà non è vissuta sulla propria pelle spesso sembra banale e la soluzione a portata di mano. Ed è proprio l’accento sull’agire (“dovresti far così”), derivante dal senso di impotenza di chi ascolta, che svilisce il vissuto di chi soffre, anche se il consiglio viene dato in buona fede, in casi peggiori col malcelato intento di mettere a tacere una lamentela ritenuta fastidiosa, o sottilmente e più o meno consapevolmente di mettere in mostra le proprie superiori capacità di far fronte agli eventi avversi.
Ancora occorre combattere contro questo stereotipo che associa la richiesta di aiuto con una presunta maggiore fragilità, perché proteggersi dall’immagine di debolezza, rimanendo lungo tempo incastrati in una difficoltà, non fa diventare più forti, e spesso incide negativamente proprio sullo scopo di mantenere di sé una buona immagine, oltre a prolungare inutilmente la tribolazione.
La presenza di un circolo vizioso segnala che siamo di fronte a una risorsa da costruire. Il paziente non è mai passivo in questo processo, partecipa agli obiettivi da stabilire, guida il terapeuta all’interno del proprio mondo e si mette in gioco durante le varie fasi dell’intervento. Il compito del terapeuta è rimuovere gli ostacoli all’accesso alle capacità del paziente di gestire emozioni, situazioni stressanti e relazioni difficili, le conoscenze e le tecniche del terapeuta nel costruire o migliorare un’abilità vengono applicate dal paziente stesso su di sé e rimangono poi ad arricchire il numero di frecce al proprio arco.
Il processo di miglioramento e di guarigione è di proprietà del paziente, nessuno si può sostituire a lui nel lavoro terapeutico. E la prima fatica è la disponibilità a mettere sul tavolo questioni scottanti, raccontare a se stessi quello che si vive e com’è stare nella propria pelle. Poi nel corso della terapia sono anche cose più concrete da fare: sperimentare modalità nuove di azione, diversi atteggiamenti nei confronti dei propri stati interni, e le varie tecniche che il terapeuta tirerà fuori dalla sua valigetta degli attrezzi, di cui poi il paziente si fa una copia ad uso personale. Ma la disponibilità alla auto conoscenza e al cambiamento è il primo imprescindibile passo. Non serve quindi una bacchetta magica, non è necessaria, anzi sarebbe controproducente: impedirebbe alla persona di attivarsi per il proprio benessere, acquisire consapevolezza e vedersi agire efficacemente per migliorare la propria qualità di vita.
(Cecilia Lombardo)
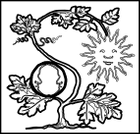

2 thoughts on “Non ho la bacchetta magica (e forse è meglio così)”-
Pingback: Psicoterapia Cognitiva – Grosseto
-
Pingback: Approfondimenti | Psicoterapia Cognitiva - Grosseto
Comments are closed.