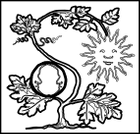di
Francescamaria Gori
Il quiet quitting, neologismo che significa “abbandono silenzioso”, è un nuovo fenomeno che interessa la sfera lavorativa e che indica l’idea di disimpegnarsi, allontanarsi, staccarsi dal proprio lavoro, limitando l’attività lavorativa agli orari e alle mansioni indicate nel contratto. Un tipo di distacco non eclatante e rumoroso, ma un lento allontanamento che elimina dall’idea del lavoro l’eccessiva dedizione, la disponibilità in ogni momento, la reperibilità costante. Con il quiet quitting ciò che si guadagna è tempo ritrovato da dedicare alla famiglia, agli amici e agli interessi personali. È un fenomeno che spinge a ripensare al lavoro tenendo in considerazione molti fattori come il benessere personale, lo sviluppo dei talenti personali e il bilanciamento vita-lavoro.
Gli individui che sposano questa idea, che sembra trasformarsi in una filosofia di vita, scelgono consapevolmente di dedicarsi al lavoro, e ai conseguenti impegni e responsabilità, solo nell’arco di determinati orari concordati e prestabiliti. Succede quindi che, piuttosto che licenziarsi dalla posizione ricoperta perché fonte di stress e stanchezza, viene scelto di impegnarsi solo lo stretto indispensabile per iniziare a godersi finalmente il tempo libero.
Il neologismo “quiet quitting” è nato sui social network ed è stato coniato da Zaid Khan (@Zaidleppelin), un giovane ingegnere statunitense di 25 anni, che, con un video pubblicato su TikTok diventato virale con più di 3 milioni di visualizzazioni, ha reso popolare questa espressione. “Il tuo valore come persona non è definito dal tuo lavoro”: da questa frase il fenomeno è diventato trend topic diffondendosi a macchia d’olio sui social. È sufficiente fare un rapido giro sui social media per vedere come l’hahstag #quietquitting sta spopolando tra persone di ogni età, soprattutto tra i millennial più giovani e gli appartenenti alla Generazione Z. Nel video sono descritti in maniera sintetica i tratti essenziali del quiet quitting. Si tratta di svolgere il proprio lavoro, non andando però “al di sopra e oltre (above and beyond)” del proprio ruolo. “Continui a portare avanti i tuoi doveri, ma non sottoscrivi più i dettami di una cultura che impone che il tuo lavoro sia la tua vita, una mentalità per cui questo ti definisce e ti completa”. La cultura del quiet quitting punta a mettere dei confini tra sé e la propria professione, qualunque essa sia. Quando le ore di lavoro finiscono si torna a casa e si pensa alla vita privata: non si è tenuti, secondo questa filosofia, a portarsi a casa pensieri, preoccupazioni o ansie dall’ufficio. Il punto non è smettere di lavorare o rinunciare alle proprie ambizioni per fare il minimo indispensabile, ma, al contrario, distanziarsi da quel sistema tossico in cui più si dà e più viene richiesto, in un loop in cui emerge (in negativo) solo chi non si adegua. Un atteggiamento che descrive il desiderio di slegare l’identità personale dalla carriera, rifiutandosi di mettere il lavoro al centro della propria vita, boicottando l’idea che la produttività abbia la meglio su tutto, perché di fatto, non se ne riconoscono i vantaggi. In pratica, ci si limita a svolgere soltanto le mansioni richieste. Né più, né meno.
Questa tendenza coinvolge pertanto soprattutto le nuove generazioni, forti di una trasformazione concettuale del lavoro in termini di tempo, sforzo e attaccamento. Possiamo considerarlo un movimento di “ribellione” al pari della “Great Resegnation” il boom mondiale di dimissioni volontarie che ha caratterizzato il 2021, perché segna una spaccatura epocale con il modello Stacanovista. Soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni, la scelta alla base è quella di non assecondare più l’approccio della performance eccellente a tutti i costi. Ci si allontana così dalla storica “hustel culture”, secondo la quale ciò che conta nella vita di ogni individuo è lavorare sempre di più, implementare la propria carriera ed ambire a traguardi professionali sempre più alti.
Imparare a disinnescare, lasciar correre, non sovraccaricare, respirare: il lavoro e la carriera non sono più le uniche priorità delle persone che, invece, scelgono di riprendere in mano la propria vita e avere più tempo da dedicare a sé stessi, alla famiglia, agli amici e alle passioni. Questo nuovo approccio si sta imponendo come Zeitgeist, come spirito dei tempi. Dopo tre anni di pandemia, una guerra, il caro vita, l’inflazione e i venti di burrasca che la crisi energetica promette di scatenare per questo inverno, la cultura del lavoro e del sacrificio a tutti i costi non esercita più quell’irresistibile appeal di un tempo.
Millennials e generazione Z sono stati spinti giorno dopo giorno a credere che solo producendo ed essendo ambiziosi e dando il massimo anche per compensi non all’altezza dello sforzo, si possa essere in grado di vivere una vita appagante. La realtà è che migliaia di persone si trovano bloccate in situazioni altamente stressanti, esigenti e inutilmente frustranti, con stipendi bassi, straordinari non pagati, reperibilità h24, alla faccia del diritto alla disconnessione. Il pensiero dominante nell’attuale mercato del lavoro è che lo stress, l’ansia da prestazione e le poche soddisfazioni economiche sono condizioni normali da vivere quotidianamente per ambire ad uno stile di vita precostituito ma la realtà è che negli anni è diventato poco più che un miraggio. Dopo decenni in cui pareva che il futuro dovesse coincidere necessariamente con il progresso, ora che anche la globalizzazione ha dimostrato la propria fallibilità e si preparano nuovi equilibri mondiali, la sensazione di imponderabilità prevale su tutto. Che fare allora? Ridimensionare. Ridimensionare e correggere l’idea che il nostro lavoro definisca il nostro valore personale. Come? Ritirandosi lentamente dal superlavoro.
Facendo riferimento alla traduzione letterale del termine dove “quit” significa “smettere”, “abbandonare”, il rischio è di porre i quiet quitters sotto una luce negativa, considerando il fenomeno come la loro volontà di svolgere il minor lavoro possibile e di fare il minimo sindacabile. Estendendo il significato, invece, appare chiaro come al centro del fenomeno non ci sia il lavoratore o la lavoratrice, intesi come persone che producono, ma come esseri umani.
Come è facile immaginare, una visione del genere non mette però d’accordo tutti gli attori coinvolti. Come ogni nuovo “trend” che si rispetti questa filosofia divide le masse: da una parte c’è chi sostiene sia una scappatoia dalle pressioni lavorative, dall’altra c’è chi pensa sia una denuncia verso un mondo del lavoro non più così appetibile e meritocratico.
Stiamo vivendo ad un vero e proprio scontro di mentalità a livello generazionale, dove la mentalità dei boomer (attuale classe dirigenziale) è totalmente contrapposta a quella dei loro sottoposti Millennials e GenZ. Generalizzando, per un dirigente Boomer sono importanti: la presenza in ufficio, il rispetto religioso dell’autorità, il fatto che l’azienda diventi la ragione di vita, per i Millennials e la Generazione Z è invece importante fare un lavoro che piace, sentirsi coinvolti, sentire uno scopo, avere valori congruenti con quelli di azienda e dirigenti.
A chi interpreta il quiet quitting come un incoraggiare le persone a essere pigre gli utenti di TikTok a favore del quiet quitting rimandano al mittente che piuttosto che incoraggiare le persone ad essere pigre, il vero significato del quiet quitting è ricordarsi di non lavorare fino al burnout. Affermano che non cambia il proprio impegno, sia a livello quantitativo che qualitativo, ma che l’adozione di un comportamento del genere garantisca meno stress e più equilibrio psico-fisico.
Ci sono persone che non riescono mai a staccare la spina, che passano gran parte della loro esistenza a lavorare, che sentono il bisogno, quasi ossessivo, di riempire l’agenda, anche degli impegni più inutili, per non sprofondare nel vortice del dolce far niente. Quando lavorano sembra a loro quasi scontato essere immerse nei progetti e farsi assorbire completamente da essi, tanto che il resto diventa un corollario. Sono le persone che, inconsapevolmente, sono già vittime delle conseguenze di quel mito della produttività al quale il mondo del lavoro è ancora fortemente ancorato.
Tutto questo fa parte della vita di molti, certo, ma chi dice che debba essere per forza così?
Ci troviamo in un’epoca in cui non tutti sono più disposti ad accettare condizioni di lavoro che non rendono felici o non garantiscono adeguati livelli di equilibrio sul piano personale, anche se a queste vengono associate retribuzioni consone: da qui anche il dilagare del fenomeno del downshifting, in cui si “scala marcia” e si sceglie volontariamente di tornare indietro per vivere meglio, anche se si rinuncia a benefici che sembravano indispensabili e invece non lo sono. Il lavoro è una parte fondamentale della vita delle persone ma quando comincia a fagocitare ogni giorno e ogni ora della quotidianità, allora c’è un problema. Lavorare per vivere è molto diverso dal vivere per lavorare ed è questo il concetto alla base del quiet quitting. Stabilire dei limiti quando si lavora, non sovraccaricarsi, non dire sì a tutta una serie di straordinari può essere vitale per il nostro equilibrio psicofisico. Produrre, macinare task, essere notati per l’instancabile impegno, è deleterio per il benessere mentale e fisico. Non andare oltre con il carico di lavoro che spetta non significa smettere di lavorare o essere un cattivo professionista. Vuol dire dare il giusto valore al proprio lavoro, far sì che faccia parte della nostra giornata e non che ne diventi la parte preponderante.
La Gallup & Robinson, una famosa società di ricerche di mercato indipendente specializzata nella ricerca pubblicitaria, ha realizzato uno studio intitolato “State of the global workplace 2022 Report”.
Da questa ricerca risulta che solo il 21% dei dipendenti è sinceramente coinvolto nella propria attività lavorativa e il 33% si considera in una condizione di crescita e benessere.
Il 44% del campione sperimenta vissuti di stress giornalieri, evidenziando un malessere psicologico diffuso e la maggior parte non pensa che la sua occupazione abbia davvero uno scopo o un significato profondo.
Con questi presupposti, il quiet quitting sembra una risposta più che logica. Quello che è certo è che questo nuovo fenomeno, per quanto a prima vista sia un atteggiamento comprensibile, richiede studi approfonditi. Lo sciame di movimenti che ha scosso il mondo del lavoro è indice di una restaurazione profonda che privilegia l’equilibrio vita/lavoro. È evidente però che l’insoddisfazione e la frustrazione delle lavoratrici e dei lavoratori abbiano giocato un ruolo fondamentale in questo cambiamento. Tanti sono gli elementi in ballo per capire la reale portata e le conseguenze del quiet quitting sui lavoratori e le lavoratrici: gli scopi che muovono le persone, le loro credenze, i loro valori, le motivazioni di ciascuno, il loro background socioeconomico e culturale, e molti altri fattori ancora. Quello che è certo è che la mentalità con cui le nuove generazioni si muovono nell’ambiente lavorativo è cambiata. Interessante sarà vedere a cosa ci porterà.